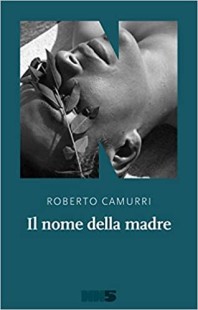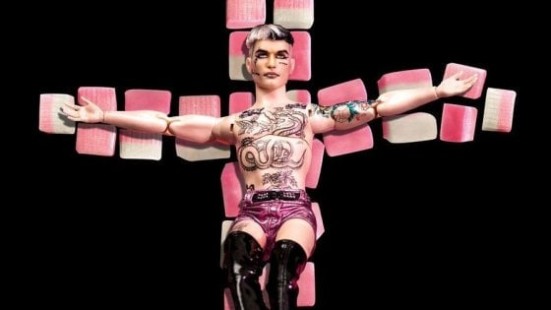Compie cinquant’anni una delle pietre miliari del jazz, Bitches brew, il doppio album, uscito per la Columbia Records il 30 marzo 1970, che segna un punto di non ritorno per la carriera di Miles Davis, rinnegando definitivamente quanto fatto fino a quel punto con una deciso rinnovamento artistico, che ha segnato nel bene e nel male il corso della musica di un intero decennio. Come spesso accade, le innovazioni non trovano consenso unanime, malgrado il grande successo di pubblico (che non è più quello del circuito jazz, cui Davis è abituato, ed è in gran parte bianco, cosa che ha un peso considerevole nel contesto sociale degli USA degli anni ’60 e in particolare per Davis). La critica, invece, lo massacra. Per i cultori l’album è il canto del cigno di Davis, basti citare il giudizio del compianto Arrigo Polillo, che pur riconoscendo in esso “il miglior disco del Davis elettronico” [quel che poteva dirsi elettronico negli anni, ’70, da non confondersi con l’elettronica degli ultimi vent’anni], reputa comunque la svolta come un suicidio artistico, dopo il quale il “trombettista ha seguito inesorabilmente la logica del mercato cui ha deciso di abituarsi“. Un giudizio decisamente severo, di chi è rimasto spiazzato dalla brutalità di Bitches brew, che però a ben vedere non è un fulmine a ciel sereno. Lo preannunciano molti segni negli anni immediatamente precedenti, a partire dal più osteggiato (e quanto è vicino in questo Davis a Dylan) dai puristi: l’elettricità. L’uso di strumenti elettrici fa la sua comparsa nella discografia di Davis con Dave Holland e Chick Corea, che nell’album Filles de Kilimanjaro (1968), sostituiscono con basso e tastiere rispettivamente il contrabasso e il piano di Ron Carter ed Herbie Hancock. Ma a cambiare in questa fase è soprattutto il suono della tromba di Miles, universalmente noto fino ad allora per la purezza lirica e cristallina, che si fa quasi sguaiata attraverso potenti amplificatori e pedali wah-wah (del resto Davis aveva progettato in quel periodo un album con Jimi Hendrix, purtroppo mai realizzato). Le ragioni della svolta sono state a lungo dibattute, tra pressioni discografiche, autentica voglia di cambiare e lusinghe di facili guadagni, ma forse la teoria più convincente è quella di Joseph Zawynul, che attribuisce all’influenza di Wayne Shorter l’evoluzione stilistica di Davis sul finire del decennio: “dovete capire che Wayne è stato con Davis per sei anni e ha contribuito a far prendere forma a quella musica. E i pezzi che ha scritto ebbero anche l’effetto di modificare, in una certa misura, quello che Miles andava facendo. Tutto cominciò quando Wayne scrisse Nefertiti [per l’album omonimo del secondo quintetto di Davis, registrato nell’estate del ’67, n.d.a.] Fu quello l’inizio di un mondo nuovo“. E bisogna sottolineare, checché se ne dica, che quel mondo nuovo è davvero poco rock. La struttura delle performance (da Kind of blue in poi la performance stessa è la composizione, concetto che qui si manifesta a pieno) non ha nulla del rock più in voga. Tutto l’album è retto da una rutilante, tribale, debordante e tarantolata sezione ritmica, animata da un folto gruppo di musicisti composto da Lenny White (batteri), Jack DeJohnette (batteria), Don Alias (percussioni e batteria), Juma Santos (percussioni), Billy Cobham (batteria) e Airto Moreira (percussioni). Non ci sono ritornelli da cantare, né gustosi riff hard rock blues, complesse architetture armoniche, nè sviluppi melodici ammiccanti. Come ricorderà lo stesso Davis nella sua Autobiografia :”quello che suonammo per Bitches Brew, sarebbe impossibile scriverlo e farlo suonare ad un’orchestra, ed è per questo che non lo scrissi… tutto…“. Ma è lo stesso Davis a generare il fraintendimento di una sua deriva rock affermando in quelle stesse pagine: “cominciai a capire che i musicisti rock non sapevano niente della musica. Non la studiavano, non potevano studiare stili differenti, e di leggerla non se ne parlava nemmeno. Ma erano popolari e vendevano un mucchio di dischi perché davano al pubblico un certo sound e quello che voleva ascoltare. Così cominciai a pensare che se loro potevano raggiungere tutta questa gente e vendere tutti quei dischi senza nemmeno sapere che cosa stessero facendo, bene, potevo farlo anch’io e per di più meglio“. Parole spietate e per certi versi opportunistiche, che avvalorano in parte le critiche di scadimento commerciale mosse al trombettista negli anni ’70, ma che al contempo evidenziano una lettura distorta che Davis aveva del rock, di cui scimmiotta l’imperizia tecnica (addirittura nel disco In a silent way dà istruzioni al chitarrista John McLughlin di suonare come se non sapesse suonare!), ma per realizzare quella che è la sua personale visione musicale. Ed è questo il segreto del successo dell’opera, che in fondo è ben più ostica della precedente produzione del musicista che, per quanto sia rimasta a lungo confinata nel ‘ristretto’ ambito del genere jazz, risulta col senno di poi più ‘easy’ di Bitches brew. Tutto si svolge all’insegno di una lunga improvvisazione, registrata nell’arco di poche sessioni ad agosto dell’anno prima, con appena esili canovacci, accordi e tempi da tenere, forniti prima di iniziare le performance da Davis alla nutrita formazione, completata da una schiera di mostri sacri da mozzare il fiato Wayne Shorter al sax soprano, Bennie Maupin al clarinetto basso, Joe Zawinul, Chick Corea e Larry Young al piano elettrico, John McLaughlin alla chitarra e Dave Holland e Harvey Brooks al basso. Un combo di quindici musicisti per un rito orgiastico senza tregua, né ripensamenti: una volta saliti sulla giostra bisogna correre fino alla fine. Catapultati dal caos metropolitano di New York a un primordiale deserto egiziano i musicisti si abbandonano alla pulsante e beduina Pharaoh’s Dance, da uno spunto di Zawinul, che occupa tutta la prima facciata del doppio vinile. Mentre la seconda è interamente occupata dalla lunghissima title track che si inerpica sulle dune di antiche sabbie per ben 27 minuti, con gli acuti distorti della tromba di Davis che riverberano nel vento di una tempesta, come dall’alto di una fortezza di fango presidiata da un drappello di uomini votati al martirio; che esce di soppiatto coperto dal buio della notte sulle note di quello che risulta essere il più fluido e avvolgente giro di basso dell’album. Restando nella metafora bellica/desertica, Spanish Key è il suono della carica di un’agguato tra le gole di un altipiano desolato, sospinto da infaticabili percussioni, che annuncia morte col tetro clarinetto di Maupin. John McLaughlin, con appena quattro minuti di durata diventa una sorta di divertissement per le doti di improvvisazione del chitarrista al quale è intitolata, mentre Miles Runs the Voodoo Down dà un’idea di cosa avrebbe voluto realizzare Davis collaborando con il più importante dei chitarristi rock, Jimi Hendrix. E dopo essersi battuta duramente l’orda di guerrieri torna alla base per dividere il bottino e ubriacarsi selvaggiamente, prima di raccogliersi in Sanctuary, in assorta, mistica meditazione.
 Lost Highways Seek your mood, Find your lost highways!
Lost Highways Seek your mood, Find your lost highways!